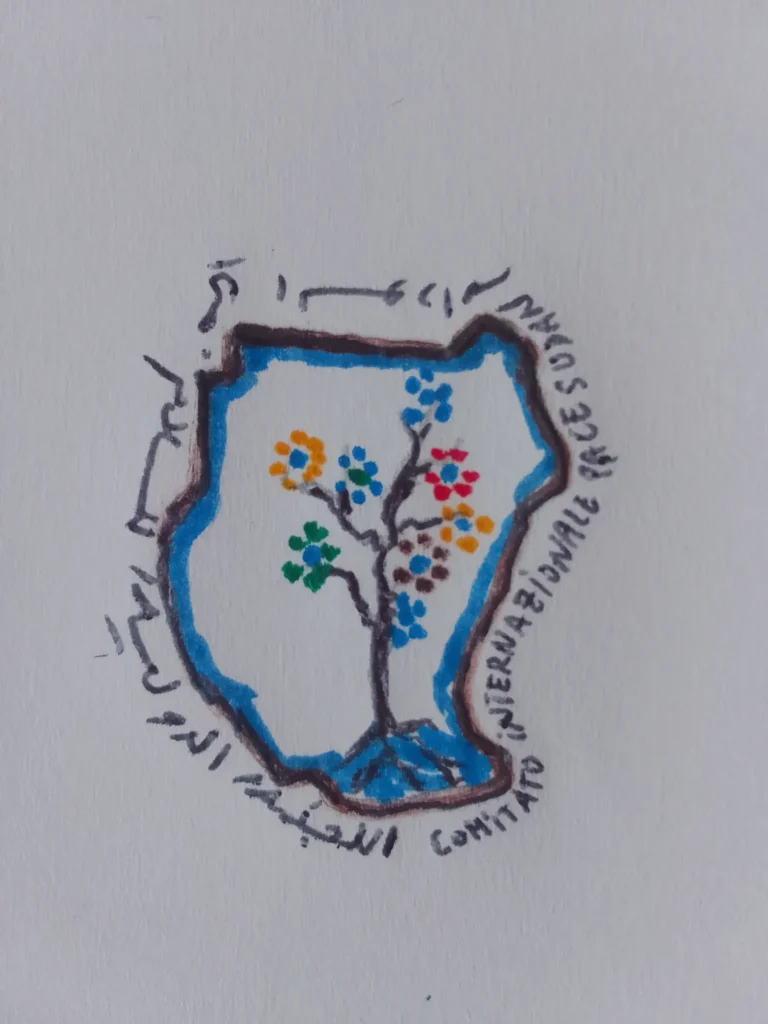Menarini, che fine hanno fatto gli autobus?
16 Novembre 2025
Casa rifugio
25 Novembre 2025Sudan, la guerra dimenticata

Foto simbolo della rivoluzione del 2018 — il treno dei ferrovieri da Atbara a Khartoum. Foto liberamente concessa dall'autore: Osama Awad Elfaki Mohamed (Sudan, Agricultural Engineer).
Intervista al Comitato Internazionale per la Pace in Sudan (CIPS), presso Bologna.
La guerra in Sudan continua a generare una delle crisi umanitarie più devastanti e meno raccontate al mondo. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi attraverso le immagini satellitari che mostrano città rase al suolo, attacchi a infrastrutture civili e i massacri sulla popolazione.
Ma, in questa tragedia umanitaria, esistono dimensioni meno visibili e più profonde che riguardano intrecci geopolitici e responsabilità internazionali. Di questo — e di molto altro — abbiamo parlato con il Comitato Internazionale per la Pace in Sudan (CIPS), organizzazione con sede a Bologna che da anni denuncia e monitora la situazione nel Paese e il sostegno esterno, diretto e indiretto, alle milizie sudanesi anche da parte dell’Europa e dell’Italia.
Avete contatti diretti con persone, attivisti, rifugiati o organizzazioni che si trovano in Sudan?
Abbiamo contatti regolari con familiari, amici, sindacalisti e attivisti che vivono soprattutto nella capitale Khartoum e in altre città della parte Nord-orientale del paese (Kasala, Madani, Port Sudan), cioè la parte controllata dalle Forze Armate sudanesi (con capitale provvisoria a Port Sudan).
In che modo monitorate la situazione sul campo?
Monitoriamo la situazione attraverso i contatti personali e i numerosi canali social attraverso i quali i sudanesi in Sudan e all’estero si scambiano informazioni. Inoltre, consultiamo regolarmente portali gestiti da giornalisti sudanesi e internazionali come Sudan Tribune (Parigi) e Radio Dabanga (Amsterdam), oltre ai principali portali globali.
È importante seguire il rapido succedersi degli eventi quotidiani, ma è altrettanto necessario mantenere una visione ampia, analizzando le cause profonde — interne, regionali, internazionali e storiche — del conflitto.
Il 6 novembre avete reso pubblico un appello alle istituzioni italiane denunciando la complicità del nostro Paese e chiedendo un embargo sull’export di armi verso gli Emirati Arabi Uniti: avete ricevuto riscontri?
No. E vogliamo sottolineare l’importanza di seguire la filiera delle armi che alimentano la guerra.
Non basta esprimere solidarietà alle vittime civili del Sudan: bisogna impedire che la guerra venga alimentata da potenze straniere come gli Emirati Arabi Uniti, che forniscono armi alle Rapid Support Forces (RSF). Sono quelle stesse milizie che hanno rotto l’assedio della città di El-Fasher il 26 ottobre 2025, commettendo crimini di guerra e crimini contro l’umanità contro civili innocenti.
Il 14 novembre si è tenuta una riunione d’emergenza alle Nazioni Unite dove si è discusso proprio della tragica situazione in Sudan. Cosa è emerso?
La sessione speciale del Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU su El-Fasher si è conclusa con una dichiarazione congiunta che contiene buone intenzioni, ma nessuna misura concreta capace di influire sul conflitto.
Sul piano diplomatico, l’unica iniziativa attiva è quella del “Quartetto” composto da Stati Uniti, Arabia Saudita, Egitto, Emirati Arabi Uniti. Ma è uno strumento inefficace perché:
1. esclude il governo sudanese e l’opposizione democratica;
2. comprende paesi che armano direttamente le due parti in guerra;
3. è influenzato da interessi economici e strategici sul Mar Rosso.
La crisi sudanese riceve un’adeguata copertura mediatica secondo Voi?
La crisi sudanese, come molti altri conflitti, non riceve un’adeguata copertura mediatica. E anche quando se ne parla, spesso manca una spiegazione chiara delle cause e delle responsabilità.
Secondo il CIPS, per comprendere cosa sta accadendo oggi in Sudan non basta seguire i movimenti sul campo: bisogna guardare alle scelte politiche, militari ed economiche compiute dall’Europa e da altri attori internazionali negli ultimi anni.
Proprio per questo, il Comitato evidenzia il rapporto dello studioso sudanese Suliman Baldo nel rapporto Border Control from Hell” (Enough Project, 2017), in cui l’autore analizza come le politiche europee sul controllo dei flussi migratori abbiano finito per rafforzare proprio una delle forze armate oggi più violente e potenti del Paese.
Il rapporto Baldo: un tassello fondamentale per capire la guerra
Lo studio è citato dal CIPS perché documenta una verità spesso ignorata ma fondamentale: le RSF non sono cresciute da sole. Molte delle risorse, delle attrezzature e della formazione che hanno ricevuto provengono da programmi europei nati per controllare le rotte migratorie.
“C’è un punto sul quale vogliamo porre l’attenzione: l’Unione Europea — e l’Italia in particolare — ha finanziato e addestrato le RSF dal 2016, assegnando loro il compito di “contenere” i migranti nel quadro dei programmi sul controllo delle frontiere. Questo ha rafforzato enormemente le ambizioni di Hemetti, al punto da spingerlo a scatenare la guerra contro lo Stato sudanese nel 2023 e a dichiarare un governo parallelo nell’Ovest del Paese nel 2025”
Questa stessa dinamica è stata descritta con estrema chiarezza proprio nel rapporto citato dove l’autore metteva in guardia dal rischio di legittimare una milizia implicata in crimini gravissimi, trasformandola di fatto in una “forza di frontiera” partner dell’Europa.
Secondo Baldo, infatti, l’UE ha destinato milioni di euro al Sudan per la “gestione delle frontiere”: fondi che nella pratica si sono tradotti in attrezzature, software, mezzi e supporto logistico finiti nelle mani delle RSF. Una cooperazione che, pur indirettamente, ha consolidato il loro potere e la loro capacità di controllare interi territori e rotte migratorie.
Il rapporto ricorda come questa collaborazione abbia contribuito a normalizzare le RSF come attore statale, nonostante la loro origine diretta nelle milizie Janjaweed, responsabili di massacri, violenze sessuali e sfollamenti forzati in Darfur.
Proprio quelle dinamiche hanno anticipato la guerra civile esplosa nel 2023, di cui oggi la popolazione paga le conseguenze più tragiche.
Oltre la guerra: il Sudan come campo di battaglia internazionale
La testimonianza del CIPS e i dati del rapporto Baldo restituiscono un quadro che va oltre la guerra raccontata semplicisticamente come uno scontro tra esercito e milizie: il Sudan è diventato un campo di battaglia internazionale, le cui radici sono profonde e dove attori regionali e globali inseguono interessi economici e strategici diversi.
Se precedentemente abbiamo osservato dall’alto la devastazione materiale del conflitto, oggi emerge un altro livello altrettanto importante della crisi: quello delle responsabilità politiche esterne e delle scelte internazionali che hanno contribuito ad alimentare la crisi sudanese.
Comprendere questo intreccio di poteri è indispensabile per immaginare una via d’uscita. Senza una revisione profonda delle politiche internazionali — a partire proprio da quelle europee — parlare di pace in Sudan rischia di rimanere un esercizio retorico.