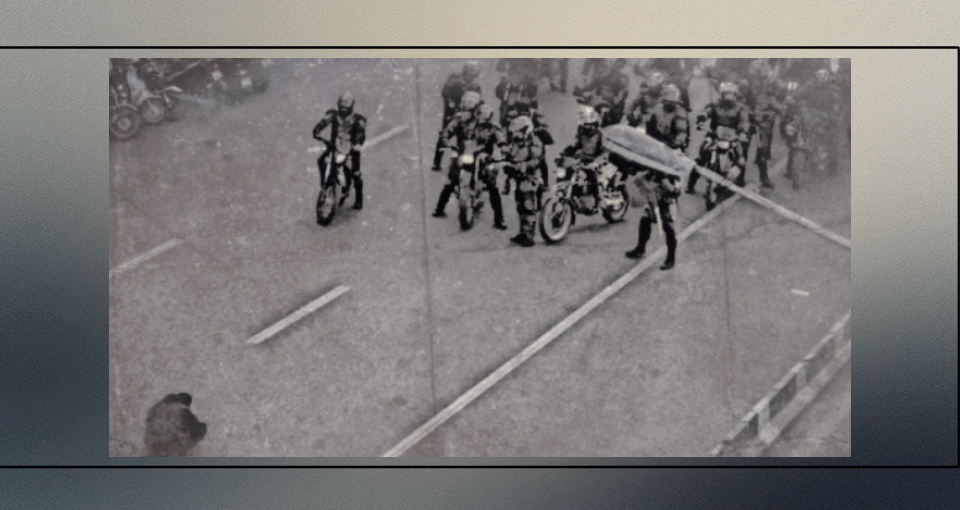L’elogio della Generazione X
2 Agosto 2025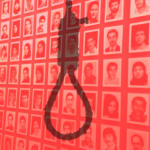
Iran: almeno 110 persone giustiziate a Luglio. È in corso un massacro simile a quello del 1988?
11 Agosto 2025Università Americane: storia e futuro

Le università americane rappresentano oggi uno dei sistemi accademici più influenti e variegati del mondo, ma le loro origini raccontano una storia di emancipazione, autonomia e tensione tra sapere e potere. Nate come luoghi elitari e, al contempo, zone franche rispetto al controllo politico diretto, hanno attraversato secoli di trasformazioni, riflettendo e spesso guidando i mutamenti sociali e culturali della nazione.
Quando nascono le università americane
I primi atenei statunitensi nacquero nel XVII secolo, in epoca coloniale. Harvard, fondata nel 1636 nella colonia del Massachusetts, fu la prima, seguita da altre istituzioni come Yale (1701), Princeton (1746), e Columbia (1754). Queste primi poli universitari avevano una forte impronta religiosa: erano pensate per formare il clero e l’élite politica, ispirandosi al modello dei college inglesi di Oxford e Cambridge. L’obiettivo era creare una classe dirigente dotata di cultura classica, preparazione teologica e disciplina morale.
Fin dalle origini, le università americane si sono distinte per una certa autonomia: erano sì fondate da comunità religiose o da colonie, ma godevano spesso di charters – statuti – che garantivano una relativa indipendenza rispetto alle autorità civili. In questo senso, si configuravano come zone franche, dove si sviluppava un pensiero critico e spesso alternativo rispetto ai poteri dominanti.
Nel tempo, questo spirito si è consolidato: tra Ottocento e Novecento, molti atenei si affrancarono dal controllo confessionale e divennero centri laici di ricerca, dibattito e progresso. Sono diventati un simbolo di emancipazione sociale: hanno aperto le sue porte a donne, afroamericani, immigrati e altri gruppi marginalizzati, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di cittadinanza e diritti.

Il Morrill Act
Con la fondazione delle università pubbliche land-grant colleges a partire dal 1862, grazie al Morrill Act, il sistema si estese oltre le élite della costa Est. Queste nuove realtà, spesso nate nei territori dell’Ovest, miravano a offrire istruzione pratica in agricoltura, ingegneria, scienze e mestieri. La loro funzione ben presto si trasformò: non più solo custode della cultura classica, ma anche motore di innovazione scientifica e progresso economico.
All’inizio del XX secolo, con la nascita dei grandi centri di ricerca come MIT, Stanford, University of Chicago, i centri del sapere divennero protagonisti fondamentali nella produzione di conoscenza e nell’industria tecnologica.
Durante il Novecento, e in particolare negli anni ’60 e ’70, tornarono a essere luoghi di contro-potere: epicentri delle proteste studentesche contro la guerra in modo particolare quella del Vietnam, per i diritti civili, per la libertà di parola. In quegli anni, si rafforzò l’idea della scuola come spazio libero in cui si può criticare, discutere apertamente, sperimentare nuovi modi di vivere e pensare.
Negli ultimi decenni, tuttavia, il sistema universitario americano ha subito cambiamenti profondi. L’aumento esponenziale delle tasse universitarie, la crescente dipendenza da fondi privati e da logiche aziendali, – corporate university – l’ingresso massiccio di studenti internazionali, e la pressione per una formazione “utile” al mercato del lavoro, hanno messo in discussione il ruolo originario di questi centri del sapere come zona franca e autonoma.
Molti analisti parlano oggi di una “crisi dell’università”, dove la ricerca è orientata al profitto e la cultura umanistica perde centralità. Tuttavia, continuano ad emergere – dentro e fuori l’accademie – movimenti che rivendicano l’università come spazio di resistenza, inclusione, creatività e pensiero critico.
Nella primavera del 2025, gli atenei statunitensi sono tornati al centro del dibattito nazionale e internazionale. In seguito all’escalation del conflitto israelo-palestinese, migliaia di studenti hanno occupato svariati campus da Columbia a UCLA, da Harvard a Berkeley, per chiedere il disinvestimento dai fondi legati all’industria bellica israeliana e una presa di posizione netta contro l’occupazione dei Territori Palestinesi.
Tuttavia, la risposta istituzionale è stata dura: sgomberi forzati, sospensioni, arresti, e l’intervento diretto di alcuni governatori. Le proteste sono state subito travolte da un’ondata di accuse: molti media e politici hanno etichettato i cortei come focolai di antisemitismo, ponendo in secondo piano le rivendicazioni politiche e umanitarie degli studenti.
Il risultato è stato una frattura culturale e politica profonda. Da un lato, una generazione studentesca che rivendica il diritto di criticare la politica israeliana senza essere tacciata di odio antisemita; dall’altro, una reazione bipartisan che ha portato molti centri del sapere ad adottare misure disciplinari drastiche, temendo ripercussioni legali e la perdita di sovvenzioni da parte di donatori privati e istituzioni governative.
Questo clima ha avuto conseguenze dirette anche sul piano elettorale. L’insicurezza percepita nei campus, l’accusa alle università di essere diventate “incontrollabili” e l’idea che la sinistra democratica fosse indulgente verso posizioni ritenute estreme, hanno alimentato un’ondata di consenso conservatore. In molte aree chiave, soprattutto tra elettori indipendenti e moderati, questa visione ha inciso profondamente.

Analisti sostengono che anche le tensioni universitarie possono aver contribuito al ritorno di Donald Trump alla presidenza. La sua campagna ha fatto leva sul “caos nei campus”, promettendo ordine, repressione del dissenso giudicato “antisociale” e una difesa intransigente di Israele come alleato strategico.
Le accuse di antisemitismo, da parte dell’amministrazione repubblicana hanno giustificato poi la sospensione di miliardi di dollari in aiuti destinati a ricerca, borse di studio e programmi pubblici.

Columbia, Harvard, Cornell, Northwestern hanno subito tagli senza precedenti, causando licenziamenti, blocchi alle assunzioni e riduzioni nei programmi di studio. Molti accademici hanno denunciato questi tagli come una forma di pressione politica, mirata a soffocare il dissenso e a riplasmare il ruolo di queste istituzioni secondo una linea ideologica più rigida.