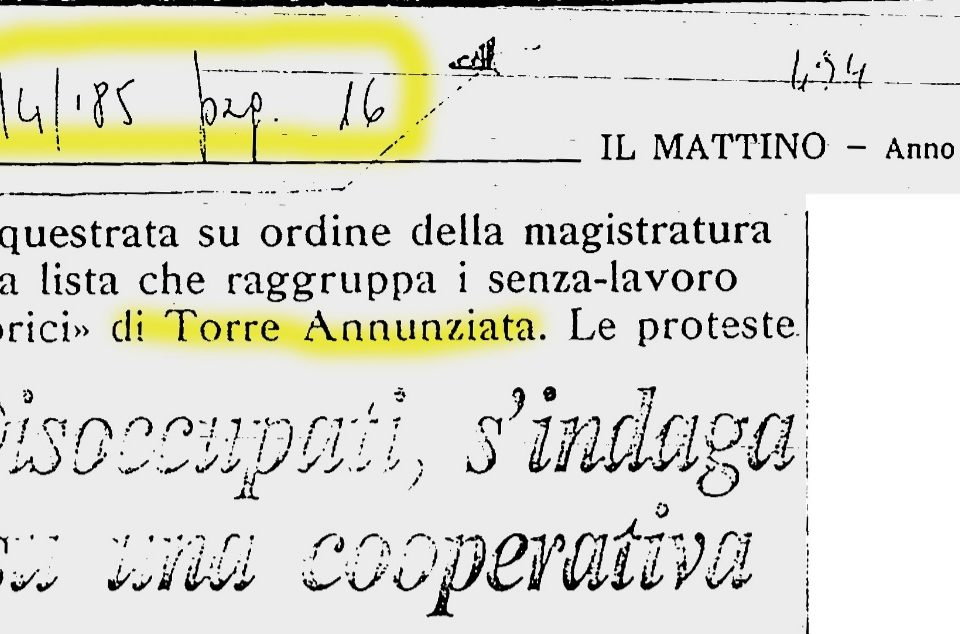Quanto costa affittare o comprare casa a Milano? I numeri da capogiro
24 Novembre 2022
Reddito di cittadinanza, ecco le novità
26 Novembre 2022Case rifugio, cosa sono e come funzionano

Dopo essere stati ospiti diversi mesi fa di una casa rifugio per donne che hanno subito violenza, ci siamo ritornati. Questa volta per raccontare come sono organizzate queste strutture e come sono impostati i progetti per l’autonomia, lavoro, scuola e nuova vita, abbiamo incontrato MondoDonna onlus.
Cosa sono le Case rifugio
In uno Stato come l’Italia in cui la violenza sulle donne rimane ancora una questione irrisolta, la presenza omogenea sul territorio di strutture sicure in cui poterle collocare resta prioritaria. I centri antiviolenza, ma in modo particolare le case rifugio, sono fondamentali per l’attuazione delle misure di salvaguardia a loro dedicate, considerato che anche la pandemia ha avuto un ruolo di incidenza nelle richieste di aiuto, facendole salire vertiginosamente. Nella fattispecie le case rifugio sono luoghi dedicati, quasi sempre a indirizzo segreto, che forniscono un alloggio alle donne che subiscono violenza di qualsiasi genere. Queste strutture che garantiscono l’anonimato e la riservatezza, offrono gratuitamente elementi primari e sono luoghi dove si intraprende un percorso di allontanamento sia emotivo, che fisico dai maltrattanti e dove si cerca di far ricostruire la propria autonomia e indipendenza. L’ospitalità viene assicurata fino a un massimo di sei mesi, ma può raggiungere anche un anno. Da un report Istat condotto nel 2019 le case rifugio per le donne maltrattate attive nel 2018 erano 222 con una concentrazione maggiore al Nord, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e al Centro in Toscana. Mediamente i posti letto messi a disposizione sono stati 8,9. Le Case Rifugio hanno ospitato nel 2018 in totale 1940 donne, di cui il 62,1% composto da straniere. Quasi la totalità delle case non prevede criteri di accesso a donne con disagio mentale, non autosufficienti o che abusano di sostanze stupefacenti. Oltre all’ospitalità le case gestiscono in collaborazione con i servizi territoriali anche altre prestazioni, come la consulenza psicologica, l’indirizzo dell’autonomia abitativa e lavorativa, il supporto e la consulenza legale. Il canale attraverso il quale le donne si sono avvicinate maggiormente alle case protette è stato quello dei servizi territoriali, che rappresentano per il 30% delle donne la via di segnalazione e indirizzamento alla protezione e alla residenza offerti dalle case rifugio. Nel 2018 la metà delle donne che hanno lasciato le case ha concluso il percorso di uscita dalla violenza e il 7,8% per conclusione del percorso di ospitalità, con un esito positivo per circa 6 donne su 10. Solo il 5,9% delle case dichiara di non aver previsto alcun sistema di sicurezza, mentre l’86,9% presenta rigidi protocolli sulla segretezza del luogo, unita a altre misure come la presenza di una linea telefonica diretta con forze di polizia, il servizio di portineria, il servizio di sorveglianza notturna o il servizio di allarme. Il 90,1% delle case rifugio prevede inoltre la reperibilità telefonica h24 dedicata alle donne ospitate. Solo il 15% delle case opera in locali di loro proprietà, il 46% è in locazione, mentre il restante 39% è in comodato d’uso o usufruisce di locali a titolo gratuito. Le operatrici che lavorano nelle case sono 1997 di queste 705 impegnate esclusivamente in forma volontaria. Fra le 12 figure professionali di cui più frequentemente si avvalgono le case rifugio, quelle delle coordinatrici, delle educatrici, delle psicologhe, delle operatrici di accoglienza, delle avvocatesse. I servizi e le attività promosse dalle case sono numerosi e differenziati e ciò richiede continui e cospicui finanziamenti, che in prevalenza provengono da fonti pubbliche.

Nella nostra intervista Loretta Michelini, Presidente dell’Associazione MondoDonna Onlus, e Vittoria Ardino Presidente della SISST – Società Italiana per lo Studio dello Stress Traumatico ci descrivono meglio gli aspetti di una casa rifugio parlandoci di Casa Phoebe

presidente MondoDonna onlis
Ci volete raccontare la storia di casa Phoebe?
Casa Phoebe nasce nel giugno del 2020 e a oggi risulta essere la prima casa in Italia in cui viene adottata una visione organizzativa e di intervento trauma-orientata. Questa visione si basa su principi che tendono a integrare fra loro diversi aspetti. La casa che ospita non diviene solo un luogo che accoglie, ma un luogo che permette di lavorare con la donna, di fare un percorso. La struttura è in affitto, l’Associazione MondoDonna Onlus già la gestiva per accoglienza straordinaria. Avendo verificato che sul territorio non vi erano centri preposti ed essendo molto grande, situata in un luogo particolare, abbiamo voluto utilizzarla per questo specifico progetto. Il nome è legato all’accoglienza, Febe era una vedova che in antichità ricopriva una mansione ecclesiastica a Cencre, a est di Corinto, viene citata da San Paolo come la donna dell’accudimento e dell’ospitalità per aver assistito lui stesso e altri ammalati.
Quindi questa casa si differenzia dalle altre presenti sul territorio grazie al progetto trauma-orientato. Potete spiegarci meglio?
Da oltre 25 anni l’Associazione MondoDonna Onlus si occupa di violenza, ma con questo progetto sperimentale ci siamo volute spingere oltre per fornire il nostro aiuto. La prima casa che abbiamo inaugurato è stata a Cattolica e, con il trascorrere del tempo, abbiamo notato che le vittime che accoglievamo erano sempre più fragili e sofferenti. Seppure consapevoli di dover ricorrere a strutture più specifiche, l’ipotesi di centri psichiatrici non convinceva, perché queste donne, proprio per la complessità dei loro percorsi, non dovevano essere trattate come malate psichiatriche. Attraverso l’incontro con Vittoria, Presidente della SISST, abbiamo potuto iniziare a lavorare per le donne attraverso loro stesse, che aiutate dalle operatrici, sono state direttamente chiamate in causa. Noi offriamo supporto, non le releghiamo al ruolo di pazienti, chiamiamo in causa tutte le persone che vengono in contatto con loro, considerato che questo progetto riconosce la visione sistemica.
Come vengono selezionati gli operatori? Ho notato che sono principalmente donne, esiste un motivo di corrispondenza di genere?
Gli operatori sono donne per due importanti motivi, nella cura domestica sono principalmente le donne a occuparsi degli altri e nello specifico per quanto riguarda le case rifugio, delle figure maschili potrebbero riattivare una risposta post traumatica. Le conseguenze del trauma psicologico richiedono una specifica attenzione, vengono coinvolti psicologi e assistenti sociali. Casa Phoebe cerca di avvalersi di sistemi informativi cercando di interagire nei vari linguaggi, non è stato semplice trovare un linguaggio comune traducendolo poi in azioni. La lente del trauma va oltre il comportamento e va a collegare gli effetti non risolti dell’esperienza. Nell’equipe gli operatori osservano e traducono andando a approfondire anche con strumenti specifici che impattano nella quotidianità. Ci stiamo attrezzando per problematiche più significative, cercando di lavorare in modo attivo sulle ferite. Questo lavoro profondo che può permettere a una donna di liberarsi, permette anche a noi di sperimentare la possibilità della sua vita in una diversa dimensione.
Cosa si aspettano le utenti una volta entrate in protezione?
Non hanno aspettative, sono donne che non vogliono entrare, non vogliono condividere, la costruzione del progetto è sempre molto ambivalente rispetto al trauma, pur consapevoli di aver lasciato una situazione di violenza hanno spesso una spinta a volerne tornare a far parte.
Quali sono i numeri delle vostre assistite da quando la casa è stata istituita?
La struttura ha 14 posti letto complessivi, di cui 4 dedicati alla pronta accoglienza e, da quando è stata aperta, sono state accolte 11 donne sole, 13 nuclei e 17 minori. Di cui donne/nuclei accolti in pronta accoglienza 9 e due donne in stato di gravidanza. Inoltre, tramite il progetto Oltre la Strada, sono state accolte 2 donne vittime di tratta.
Nella struttura quali sono le nazionalità maggiormente diffuse fra le ospiti?
Le nazionalità più diffuse fra le nostre ospiti sono state Romania, Bangladesh, Congo, Mali, Italia, Marocco, Russia, Polonia, Pakistan, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Ceca.

Avete qualche storia che vi ha colpite, che desiderate condividere?
Abbiamo ospitato una donna che con il tempo è divenuta molto aggressiva con a carico anche dei minori. Il suo comportamento ha avuto un impatto molto forte sull’intera équipe causando un effetto psicologico sulle operatrici stesse. La presenza di questa donna ha avuto conseguenze destabilizzanti e, in casi come questo, è stato necessario mettere in campo delle supervisioni.
Cosa lo Stato ha fatto o potrebbe ancora fare per favorire l’apertura di nuovi centri?
Potrebbe organizzare una struttura portante, con personale qualificato, attraverso i contributi ricevuti che purtroppo però non risultano essere mai abbastanza. Lo Stato dovrebbe prevedere progetti per sostenere e mettere a disposizione risorse certe e continuative senza dimenticare le normative che garantiscano l’operatività dei centri.
È possibile far coincidere le finalità dell’associazione con le necessità di chi deve essere aiutato?
Possibile, ma molto difficile a causa del mercato del lavoro e delle differenze culturali. L’obiettivo finale per tutti è fare in modo che non venga garantita soltanto l’ospitalità, ma anche una prospettiva di vita. Riuscire a reinserire in modo adeguato nel mondo del lavoro, assottigliando le differenze culturali e le fragilità per traumi resta una priorità. Ci deve essere un accompagnamento personalizzato che consenta soprattutto il mantenimento del posto di lavoro. A causa dei ritmi lavorativi, risultano ancora oggi troppi inserimenti falliti. Cerchiamo di incoraggiare le donne affinché raggiungano una loro progettualità, in modo da farle riprendere in mano la loro vita. Se le ferite non vengono curate la possibilità di ritornare dentro la spirale di violenza è alta.
Quali sono le nuove fragilità sociali che state intravedendo e come vi state organizzando per fronteggiarle?
Non vediamo nuove fragilità, ma purtroppo quelle che già esistono diventano sempre più profonde e difficili da affiancare in un percorso di risoluzione. I traumi mai sanati, mai curati, si sovrappongono inducendoci a trovare soluzioni e strategie nuove per risolverle.

Intervista a Federica Mozzorecchia, supervisore e psicologa di casa Phoebe, e Giovanna Casciola coordinatrice dell’Area Antiviolenza per l’Associazione MondoDonna Onlus
Quali sono secondo voi le aree della società che dovrebbero essere maggiormente coinvolte nel contrasto alla violenza sulle donne?
Sicuramente la scuola e tutte le figure che lavorano o hanno a che fare con i giovani, è molto importante fare prevenzione e interagire con quelli che saranno gli adulti di domani. Inoltre una massiccia sensibilizzazione dei servizi sociali, delle Forze dell’ordine, degli ospedali che prendono in carico le donne che subiscono violenza, non necessariamente il personale può aver sviluppato la sensibilità e le competenze necessarie all’accoglienza. Infine, il lavoro da fare è sul rispetto e sulla riforma del diritto di famiglia, che descrive ancora il genere femminile relegato a determinati ruoli, per produrre un cambiamento è necessaria una sinergia fra tutti i soggetti coinvolti.
Ogni donna porta con sé un proprio vissuto e seppure il denominatore della violenza rimanga quello comune, ognuna necessita di un proprio percorso. Quanto è difficile affrontare queste diversità?
È molto complesso, l’elemento culturale, oltre alla barriera linguistica, spesso non ci permette di entrare in profondità, comunichiamo con queste donne attraverso dei mediatori culturali, non una comunicazione sempre diretta quindi. Operando sul trauma orientato andiamo a sviscerare le emozioni e talvolta non comprendendo pienamente si creano degli ostacoli.
Molte donne provengono da contesti culturali dove la religione regola anche la quotidianità, può nelle storie di violenza essere di aiuto?
È capitato che ci siano state donne che abbiano cercato di aggrapparsi alla religione. Abbiamo donne provenienti da Paesi diversi, con diverse etnie, più o meno credenti, soltanto una ha manifestato però decisi segni di miglioramento attraverso la fede, non solo in relazione alla violenza, ma alla sua fragilità interiore. Alcune di loro riescono a trovare da sole le proprie motivazioni utili all’elaborazione di quanto vissuto, cercando rassicurazioni non necessariamente nella religione, a volte può aiutare lo sport, il lavoro e la musica che diventano in questo caso una forma di cura.

Esiste una sorta di attaccamento può essere difficile lasciar andare una donna in protezione?
Chi lavora in questo ambito non può permetterselo, dobbiamo sempre essere molto chiare in quelli che sono i nostri ruoli. Le operatrici devono muoversi in uno spazio definito, non possono sostituirsi alle ospiti, non si possono far carico delle loro decisioni, come non possono divenirne amiche. Siamo lì per restituire loro capacità, cercando di ridare quello che non vedono più, di fatto dovremo funzionare come uno specchio. Certo alcune delle loro storie rimangono dentro, evitare qualsiasi forma di attaccamento fa parte del nostro lavoro e bisogna impegnarci fin dall’inizio affinché questo non accada. Piuttosto siamo felici quando ci lasciano, riteniamo sia avvenuto un passaggio evolutivo, quantomeno uno fra molti che dovranno susseguirsi. Quando le donne abbandonano la casa, seppure alcune di esse scelgano di tornare a vivere con il maltrattante, hanno comunque imparato qualcosa su loro stesse.
Come si diventa operatrice, come si sceglie questa professione? È una vocazione?
Non è una vocazione, chi lavora in questo ambito diciamo, però, che ha una storia personale che richiama l’accoglienza, ha sostenuto volontariamente o involontariamente qualcuno. Giovanna “Prima di un lavoro per me è stato un impegno politico, difendere i diritti delle donne per me era una priorità. ho fatto parte di diversi collettivi femminili. Il mio interesse politico sviluppatosi nel tempo mi ha indotta a approfondire e a voler fare formazione, poiché ho compreso che soltanto la volontà non bastava, era necessario avere degli strumenti, delle conoscenze, ho coniugato quindi i miei ideali alla pratica. Federica “Sicuramente, seppure remoto e inconsapevole, c’è sempre stato dentro di me un motivo, a partire dal percorso di studi che mi ha avvicinata alla psicologia. In realtà mi interessava più la materia che la professione, prima delle donne vittime di violenza mi occupavo di minori con disturbi psichiatrici”.
Quali potrebbero essere in base alla vostra esperienza gli strumenti ancora da mettere in campo per contrastare questa dimensione di violenza?
Dovrebbe essere messo in campo un sistema che garantisca subito alle donne che denunciano la loro credibilità, che non metta mai in discussione ciò che dicono. Troppe volte i ritardi sono stati fatali, occorre essere tempestivi. Inoltre anche i mezzi di comunicazioni dovrebbero avere un linguaggio più adeguato, spesso anche i titoli dei telegiornali sono ambigui, l’amore non deve essere mai confuso con la violenza, fin quando non si riuscirà a fare chiarezza a condannare fermamente non si otterrà un vero cambiamento culturale. Purtroppo ci stiamo abituando ma non dovrebbe essere così, c’è da modificare questa base attraverso diversi livelli di intervento, con un lavoro continuo e culturale, senza dimenticare che in alcuni Paesi non sono ancora riconosciuti diritti primari, le migranti continuano a avere discriminazioni multiple.